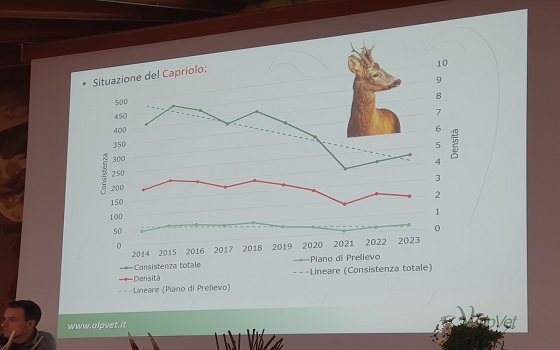Aumentano i turisti nelle aree naturali: quali conseguenze per la fauna?

di Marco Salvatori – Passeggiando sui sentieri che attraversano le foreste delle Alpi e degli Appennini non è sempre facile rendersene conto, ma il paesaggio montano è molto cambiato negli ultimi decenni. Nelle stesse zone ora coperte dalla chioma degli alberi, fino agli anni Cinquanta del secolo scorso ci saremmo trovati circondati da pascoli per il bestiame, prati da sfalcio, frutteti e terrazzamenti.
Le dinamiche del paesaggio naturale dell’Europa riflettono i cambiamenti demografici, sociali ed economici delle società umane sin dal Paleolitico: l’80% del continente Europeo era ricoperto da foreste fino a 5.000 anni fa, ma con l’imporsi dell’agricoltura e l’espansione demografica neolitica la foresta è stata bruciata, tagliata e dissodata per fare spazio a pascoli e colture. Questo processo è continuato nei secoli raggiungendo un minimo assoluto di copertura forestale, che nel nostro paese è stato toccato intorno alla metà del Novecento.
In quegli anni l’Italia ha raggiunto un momento tipico delle dinamiche socio-ecologiche moderne: il cosiddetto “punto di transizione forestale”. La crescita dell’industria e dei servizi nelle aree urbane ha richiamato larghe fette della popolazione dalle aree montuose, con il conseguente depopolamento di queste zone. L’intensificarsi delle pratiche agricole nelle regioni pianeggianti, con una produzione maggiore in estensioni sempre minori, ha ulteriormente contribuito a liberare spazio in montagne e colline, prontamente occupato dalla spontanea e naturale ricrescita delle foreste.
Finalmente libera dalla pressione umana, la vegetazione ha ripreso spontaneamente il suo corso naturale, la successione ecologica è passata attraverso gli stadi intermedi di arbusteto e boscaglia per poi concludersi con l’instaurarsi della foresta d’alto fusto. L’espansione degli habitat forestali, assieme ad altri fattori come la tutela legale garantita dalle direttiva Habitat e Uccelli dell’Unione Europea, una minor persecuzione, e alcuni progetti di reintroduzione, ha consentito di conseguenza il ritorno di molte specie animali che si erano localmente estinte.


Questo cambiamento ha naturalmente due facce: se nelle aree costiere, in quelle pianeggianti e nei fondivalle della penisola l’urbanizzazione sregolata ha divorato e continua a divorare il territorio, disegnando un paesaggio sempre più artificiale, nelle aree interne e montuose è ritornata la foresta. Ma i cambiamenti non finiscono qui: la popolazione urbana, con redditi mediamente più alti e una voglia crescente di ricollegarsi con quel mondo naturale assente dalle città e dalle aree suburbane, ha cominciato a frequentare sempre più spesso i boschi, le montagne e i parchi naturali, che nei fine-settimana e nei periodi di vacanza si affollano di persone in cerca di svago.
Si stima che entro il 2050 oltre i due terzi della popolazione mondiale vivrà in città, e in questa società sempre più urbanizzata il trascorrere del tempo immersi in ambiente naturale assicura dei dimostrati benefici psico-fisici, e contemporaneamente genera introiti economici legati al turismo.
Questo fenomeno, ormai diventato di massa, può però avere degli effetti collaterali sugli animali selvatici che abitano le mete turistiche, soprattutto se consideriamo i numeri in gioco: sono 8 miliardi ogni anno i visitatori delle aree protette a livello mondiale, l’80% dei quali concentrato in Europa e Nord America. Qui gli escursionisti sono aumentati dell’ 800% fra il 1960 e il 2020. Quali sono le conseguenze di questa diffusa presenza umana nelle aree naturali sulla fauna che le abita?
Dalle ricerche scientifiche svolte su questo tema sappiamo che la presenza delle persone in aree in cui gli animali sono sottoposti a mortalità antropogenica (come caccia, bracconaggio, investimenti stradali) o in cui sono stati perseguitati per secoli (si pensi alla decimazione dei grandi predatori come lupi e orsi in Europa occidentale) scatena delle risposte anti-predatorie. Queste risposte comprendono la fuga, l’aumento di comportamenti di vigilanza, l’utilizzo di aree di rifugio in cui è più difficile che gli esseri umani penetrino, nonché una concentrazione delle attività nelle ore notturne quando le persone sono meno attive.
Tutte queste risposte, tipiche delle prede, vengono utilizzate anche dai predatori apicali, che in natura non avrebbero predatori, ma che in presenza degli umani si comportano da prede a loro volta. Studi svolti in Scandinavia e in altre zone d’Europa ci dimostrano che anche specie normalmente non soggette a predazione, come l’orso bruno, tendono ad aumentare i livelli di vigilanza, il battito cardiaco e quindi anche lo stress in vicinanza di fonti di disturbo antropico. Anche il lupo, predatore all’apice della rete alimentare negli ecosistemi europei, reagisce alla presenza umana rifugiandosi in zone meno accessibili ed evitando aree aperte o limitrofe alle aree urbane durante il giorno, comportamenti normalmente tipici di una preda.
Una recente ricerca italiana condotta dal MUSE – Museo delle Scienze di Trento – e dall’università di Firenze, ha cercato di capire quali potessero essere gli effetti a lungo termine della frequentazione umana degli ambienti forestali all’interno e attorno ad un’area protetta delle Dolomiti. I ricercatori hanno posizionato in maniera sistematica 60 fototrappole sulla rete sentieristica, monitorando contemporaneamente il passaggio di esseri umani e quello di altre 8 specie di mammiferi (faina, volpe, lepre, tasso, capriolo, camoscio, cervo e orso) per 7 estati consecutive, dal 2015 al 2021.



Delle oltre 500 mila istantanee raccolte, il 70% ritraeva esseri umani, il cui tasso di passaggio si è rivelato 7 volte superiore a quello della specie selvatica più rilevata, cioè la volpe, e addirittura 70 volte maggiore di quello dell’orso. Il passaggio di persone, soprattutto escursionisti e ciclisti, è cresciuto nel periodo considerato ed è stato registrato sia all’interno sia all’esterno del parco naturale, indicando una potenziale pressione anche dentro l’area protetta.
Dallo studio emerge però immediatamente un dato. Nel corso degli anni la presenza delle 8 specie studiate è complessivamente in leggera crescita: alcune specie hanno mostrato tendenze stabili, altre come l’orso, il cervo e la faina persino un incremento. Si tratta di un dato rassicurante per la conservazione delle popolazioni di queste specie, fondamentali per le dinamiche ecosistemiche: la presenza diffusa di persone intente in attività ricreative non sembra complessivamente danneggiare le popolazioni di questi animali.
Parallelamente però, un altro processo è stato riscontrato dagli autori dello studio: tutte le specie studiate hanno mostrato una netta tendenza a diventare più notturne nei luoghi in cui la frequentazione umana è più alta. La proporzione di attività notturna passa da circa il 60% in siti con passaggio umano nullo o scarso al 90% nei siti più gettonati dagli escursionisti. Non solo, le specie di maggiori dimensioni, che hanno maggiori difficoltà a nascondersi, come l’orso, il cervo e il camoscio, hanno anche mostrato una chiara tendenza a evitare le zone più frequentate dalle persone, rifugiandosi nelle aree meno disturbate.
Gli animali selvatici, perciò, mettono in atto tutte le strategie a loro disposizione per minimizzare le probabilità di incontrare l’essere umano, e queste risposte sembrano avere successo nel garantire loro una buona sopravvivenza e riproduzione, viste le tendenze positive osservate.


Questi comportamenti potrebbero però non essere a costo zero per gli animali. Da altre ricerche è emerso negli ultimi anni come una concentrazione dell’attività nelle ore notturne possa potenzialmente avere ricadute negative sulla termoregolazione, la capacità di spostamento, la competizione fra specie. Allontanandosi dalle fonti di disturbo antropico le specie animali potrebbero inoltre finire per frequentare aree sub-ottimali, soprattutto in termini di alimentazione, subendone le conseguenze negative. La pacifica invasione di escursionisti nelle aree naturali genera perciò delle risposte comportamentali negli altri mammiferi, che non possono essere trascurate.
Ai gestori delle aree protette da sempre è spettato il difficile compito di conciliare la tutela della natura e della biodiversità, loro primaria missione, con la fruizione turistica, fondamentale per garantire gli introiti economici e di conseguenza il supporto delle comunità locali alle misure di conservazione.
Affinché questo difficile equilibrio sia garantito, è di fondamentale importanza misurare la sostenibilità delle attività umane, anche di quelle turistiche e ricreative, quantificandone gli effetti sugli ecosistemi e la fauna. Il sovraffollamento che molte aree protette a livello globale stanno sostenendo potrebbe essere affrontato limitando l’accesso umano in alcune zone o in alcuni periodi, minimizzando al contempo l’impatto negativo sull’economia legata al turismo, ed evitando i rischi di rendere la conservazione della natura impopolare.
Alcune strategie già oggi esistono e vengono applicate in tutto il mondo: in diverse aree protette della California, ad esempio, gli ingressi sono contingentati. Nel parco nazionale canadese di Banff invece, vengono chiuse al pubblico ogni primavera le aree attorno alle tane dei lupi, mentre nel parco statunitense di Yellowstone viene interdetto l’accesso nelle zone in cui la densità di orsi è più alta.
Anche in Italia esistono esempi di questo tipo: il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise limita l’accesso ad alcuni sentieri del parco nei periodi più sensibili per la riproduzione dell’orso bruno marsicano e del camoscio appenninico. Vista la crescente popolarità delle aree naturali come luoghi di evasione dallo stress cittadino queste misure potrebbero essere replicate a scala più ampia, in modo da garantire delle aree in cui i comportamenti naturali degli animali selvatici possano esprimersi senza interferenze.